 Il termine indie è definito nel nerdizionario come quell’ambiente lontano dall’ipertrofia sanguinolenta e dalla ricerca del fotorealismo (il Santo Graal dei giochi elettronici, “ma chi lo vuole?”), caratterizzato dalla ricerca di strade nuove da percorrere nell’ambito entertainment videoludico, i cui prodotti sono spesso il frutto di una lavorazione dai costi contenuti, editi da team emergenti, ma armati di tanta fantasia e tanta, tanta passsione.
Il termine indie è definito nel nerdizionario come quell’ambiente lontano dall’ipertrofia sanguinolenta e dalla ricerca del fotorealismo (il Santo Graal dei giochi elettronici, “ma chi lo vuole?”), caratterizzato dalla ricerca di strade nuove da percorrere nell’ambito entertainment videoludico, i cui prodotti sono spesso il frutto di una lavorazione dai costi contenuti, editi da team emergenti, ma armati di tanta fantasia e tanta, tanta passsione.
Primo classificato per l’eccellenza artistica all’Indipendent Game Festival, Machinarium è il primo gioco di una certa portata per i cechi sviluppatori di Amanita Design. Jakub Dvorsky, fondatore del team, è un inguaribile nostalgico delle care vecchie avventure punta-e-clicca e lo si può intuire provando i suoi precedenti lavori.
 Quella di Samorost è, a tutti gli effetti, una saga (Dvorsky non ha escluso l’uscita di un terzo episodio) ambientata in un allucinato universo dove umani, robot e alieni vivono nella pancia di piattaforme meteoritiche galleggianti nel cosmo. Trattasi di minigame realizzati in flash, i quali, nonostante la breve durata e un gameplay ridotto all’osso, con il solo puntatore del mouse come estensione del nostro arto ad interagire con l’ambiente, hanno destato un notevole interesse tra pubblico e critica, tanto da meritarsi il premio di miglior webgame al Seoul Net Festival del 2006. A stupire non sono tanto le meccaniche di gioco, identiche a quelle degli adventure di due decenni fa, quanto piuttosto lo stile e l’atmosfera trasognata dei loro mondi, frutto di collage di foto, disegni manuali e immagini computerizzate, riportando alla memoria l’onirismo del cinema di Michel Gondry, geniale utilizzatore dello stopmotion nel suo “L’Arte del Sogno”, tecnica di cui Jiri Barta - guarda caso maestro dei funghetti cechi - fu un rinomato utilizzatore. La ricercatezza del loro stile è da ricondurre agli studi presso l’Accademia d’Arte, Architettura e Design di Praga. Ed è questa la vera sorpresa dei loro videogiochi, la delicatezza dei disegni, l’umanizzare personaggi di latta e viscidi alieni.
Quella di Samorost è, a tutti gli effetti, una saga (Dvorsky non ha escluso l’uscita di un terzo episodio) ambientata in un allucinato universo dove umani, robot e alieni vivono nella pancia di piattaforme meteoritiche galleggianti nel cosmo. Trattasi di minigame realizzati in flash, i quali, nonostante la breve durata e un gameplay ridotto all’osso, con il solo puntatore del mouse come estensione del nostro arto ad interagire con l’ambiente, hanno destato un notevole interesse tra pubblico e critica, tanto da meritarsi il premio di miglior webgame al Seoul Net Festival del 2006. A stupire non sono tanto le meccaniche di gioco, identiche a quelle degli adventure di due decenni fa, quanto piuttosto lo stile e l’atmosfera trasognata dei loro mondi, frutto di collage di foto, disegni manuali e immagini computerizzate, riportando alla memoria l’onirismo del cinema di Michel Gondry, geniale utilizzatore dello stopmotion nel suo “L’Arte del Sogno”, tecnica di cui Jiri Barta - guarda caso maestro dei funghetti cechi - fu un rinomato utilizzatore. La ricercatezza del loro stile è da ricondurre agli studi presso l’Accademia d’Arte, Architettura e Design di Praga. Ed è questa la vera sorpresa dei loro videogiochi, la delicatezza dei disegni, l’umanizzare personaggi di latta e viscidi alieni.
Continuando su questa strada, affidandosi ancora una volta “coraggiosamente” - come affermato dallo stesso Jakub Dvorsky – a Flash, gli Amanita hanno dato alla luce il loro progetto più ambizioso.
 Un orologio non parla (almeno quelli completamente meccanici); la mia vecchia Fiat 500 non proferisce verbo, s’accende – quando ne ha voglia – e basta; il pendolo in sala, quello che nel cuore della notte fa abbaiare il cane, con il suo sofisticato meccanismo di contrappesi, ruote dentate e lancette, annuncia le ore con il semplice rintocco delle campane; in tutti questi casi, il linguaggio naturale non viene coinvolto. Perché, dunque, in un mondo che è in tutto e per tutto una ricostruzione patafisica[1] delle interiora metalliche della vecchia cipolla di mio nonno, dovrebbero esservi dialoghi fatti di parole proprie del linguaggio umano? I cittadini di Machinarium comunicano tramite impulsi binari, esemplificati attraverso le nuvolette – alcune veramente simpatiche – che dipanano via via l’ombra attorno alla trama dell’avventura. In questa, noi indossiamo i bulloni di un robot senza nome (oddio, sicuramente ce l’avrà, ma sarà un complesso codice univoco d’identificazione che non ci è dato conoscere), gettato in una discarica senza saperne il motivo. Da questo punto, senza un filmato introduttivo, senza un narratore che ci fornisca le coordinate del mondo in cui siamo precipitati, comincia la nostra missione. Innanzitutto, urge riassemblarsi, situazione presa a pretesto per farci acquisire familiarità con l’interfaccia, efficace quanto essenziale, costituita da un inventario a comparsa e dal quadro/ambiente in cui presenziamo, con tutte le possibili interazioni.
Un orologio non parla (almeno quelli completamente meccanici); la mia vecchia Fiat 500 non proferisce verbo, s’accende – quando ne ha voglia – e basta; il pendolo in sala, quello che nel cuore della notte fa abbaiare il cane, con il suo sofisticato meccanismo di contrappesi, ruote dentate e lancette, annuncia le ore con il semplice rintocco delle campane; in tutti questi casi, il linguaggio naturale non viene coinvolto. Perché, dunque, in un mondo che è in tutto e per tutto una ricostruzione patafisica[1] delle interiora metalliche della vecchia cipolla di mio nonno, dovrebbero esservi dialoghi fatti di parole proprie del linguaggio umano? I cittadini di Machinarium comunicano tramite impulsi binari, esemplificati attraverso le nuvolette – alcune veramente simpatiche – che dipanano via via l’ombra attorno alla trama dell’avventura. In questa, noi indossiamo i bulloni di un robot senza nome (oddio, sicuramente ce l’avrà, ma sarà un complesso codice univoco d’identificazione che non ci è dato conoscere), gettato in una discarica senza saperne il motivo. Da questo punto, senza un filmato introduttivo, senza un narratore che ci fornisca le coordinate del mondo in cui siamo precipitati, comincia la nostra missione. Innanzitutto, urge riassemblarsi, situazione presa a pretesto per farci acquisire familiarità con l’interfaccia, efficace quanto essenziale, costituita da un inventario a comparsa e dal quadro/ambiente in cui presenziamo, con tutte le possibili interazioni.
 Gli ostacoli rappresentano l’ideale sposalizio tra la scuola di Myst e quella classica dei giochi Lucas Arts: se da un lato abbiamo oggetti da raccogliere/combinare/consegnare per avanzare allo step successivo, da un altro ci vengono sottoposti puzzle, basati sulla fisica, spesso immaginaria, ma perfettamente logica nel contesto al quale appartiene, le cui soluzioni sono seminate nell’ambiente (ahimé, quasi sempre nella location in cui ci troviamo) o tra le sinapsi del nostro cavolfiore. Purtroppo ci troviamo di fronte al primo difetto del titolo: sebbene gli indovinelli siano tanti e di vario genere, la soluzione di questi non sempre si distanzia dal metodo fai passare tutte le possibilità, che prima o poi ci si piglia. Questo perché gli oggetti con cui interagire sono pochi e quasi tutti utili alla risoluzione di un rompicapo, con la conseguente assenza di false piste, che, come molti vecchi appassionati adventurieri ricorderanno, potevano bloccare il più fine detective-nerd del mondo per settimane. Da lodare è, in ogni caso, il modo in cui gli sviluppatori abbiano saputo incastonare le prove nell’ambiente e nel continuum, senza creare situazioni di stacco tra gioco e narrazione, alcune impregnate di un umorismo discreto, personalmente molto più gradito dell’esasperato ricorso al demenziale proprio di altri giochi, col fine di strappare a tutti i costi una risata, ottenendo quasi sempre l’effetto contrario.
Gli ostacoli rappresentano l’ideale sposalizio tra la scuola di Myst e quella classica dei giochi Lucas Arts: se da un lato abbiamo oggetti da raccogliere/combinare/consegnare per avanzare allo step successivo, da un altro ci vengono sottoposti puzzle, basati sulla fisica, spesso immaginaria, ma perfettamente logica nel contesto al quale appartiene, le cui soluzioni sono seminate nell’ambiente (ahimé, quasi sempre nella location in cui ci troviamo) o tra le sinapsi del nostro cavolfiore. Purtroppo ci troviamo di fronte al primo difetto del titolo: sebbene gli indovinelli siano tanti e di vario genere, la soluzione di questi non sempre si distanzia dal metodo fai passare tutte le possibilità, che prima o poi ci si piglia. Questo perché gli oggetti con cui interagire sono pochi e quasi tutti utili alla risoluzione di un rompicapo, con la conseguente assenza di false piste, che, come molti vecchi appassionati adventurieri ricorderanno, potevano bloccare il più fine detective-nerd del mondo per settimane. Da lodare è, in ogni caso, il modo in cui gli sviluppatori abbiano saputo incastonare le prove nell’ambiente e nel continuum, senza creare situazioni di stacco tra gioco e narrazione, alcune impregnate di un umorismo discreto, personalmente molto più gradito dell’esasperato ricorso al demenziale proprio di altri giochi, col fine di strappare a tutti i costi una risata, ottenendo quasi sempre l’effetto contrario.
 Ritornando ai primi attimi di gioco, di lì a poco incontreremo il primo sgherro della Black Cap Brotherhood, una combriccola interplanetaria di guappi con oscuri intenti non ben precisati sulla città delle macchine. Da qui in avanti, sarà una corsa ad ostacoli per sventare i loro piani e riportare l’ordine a Machinarium. Notevole, infine, gli inserimenti di fasi arcade, mai troppo difficili, mai tanto invasivi da imbastardire il concept del gioco.
Ritornando ai primi attimi di gioco, di lì a poco incontreremo il primo sgherro della Black Cap Brotherhood, una combriccola interplanetaria di guappi con oscuri intenti non ben precisati sulla città delle macchine. Da qui in avanti, sarà una corsa ad ostacoli per sventare i loro piani e riportare l’ordine a Machinarium. Notevole, infine, gli inserimenti di fasi arcade, mai troppo difficili, mai tanto invasivi da imbastardire il concept del gioco.
Come accennato più sopra, nel gioco non c’è traccia di parole. La sfida più grande, dunque, è stata quella di creare un’atmosfera ugualmente immersiva per il giocatore. È facile, prendendo ad esempio un famosissimo e – che palle – inflazionatissimo adventure sui bucanieri, coinvolgere il giocatore con dialoghi in stile cinematografico, personaggi grottescamente epici e zombiepiratinfestatidaparassiti. Al contrario, mettendo in scena un’avventura muta con protagonisti degli automi arrugginiti e tanti ostacoli cervellotici da superare, il rischio di straniamento era alto (come Myst insegna, ma, in quel caso, era voluto). Rischio scongiurato da una cura dei dettagli raffinata e appassionata nel cavare familiarità da quegli sgraziati corpi di ferro, da quei grattacieli arrugginiti, da quelle caldaie gocciolanti. Per non parlare della scriptata umanità di cui sono dotati i robot (o forse siamo noi umani ad essere scriptati come degli automi?) che traspare dall’amore sintetico del protagonista per una robottina resa schiava dalla Black Cap Brotherhood, o come la fede religiosa degli abitanti della piazza, o, ancora, il tabagismo di un robo-carcerato, più desideroso di una spipazzata che della libertà.
 Degno di menzione è il lavoro svolto sulla colonna sonora da Tomàs Dvorak, già compositrice della OST di Samorost, che le è valso il premio come soundtrack più originale al Flash Forward Award del 2006. Musicista elettronica et istrionica (non solo sintetizzatori e calcolatori nella sua vita, ma anche Dulcimer e Clarinetti), Tomàs non è solamente impegnata nel musicare videogiochi. Il suo album di debutto, Pocustone, ha destato un certo interesse presso la critica specializzata. Artista ceca più trasmessa sulle frequenze indipendenti della praghese Radio 1, ha ottenuto numerosi riconoscimenti dentro e fuori i confini nazionali anche grazie ai lavori svolti per il cinema. La collaborazione con Amanita Design è proseguita con Machinarium, per il quale la Dvorak ha mobilitato tutta la sua esperienza in ambito elettroacustico, consegnando al gioco scorci di sereno (”The Sea”), dediche raffinate alla musica degli Air (”Gameboy Tune”), schizzetti caricaturali elettronici (”The Black Cap Brotherhood Theme”). La sinergia con il comparto visivo è perfetta, facendo di questo insieme di rottami ossidati un mondo a cui ci si può affezionare.
Degno di menzione è il lavoro svolto sulla colonna sonora da Tomàs Dvorak, già compositrice della OST di Samorost, che le è valso il premio come soundtrack più originale al Flash Forward Award del 2006. Musicista elettronica et istrionica (non solo sintetizzatori e calcolatori nella sua vita, ma anche Dulcimer e Clarinetti), Tomàs non è solamente impegnata nel musicare videogiochi. Il suo album di debutto, Pocustone, ha destato un certo interesse presso la critica specializzata. Artista ceca più trasmessa sulle frequenze indipendenti della praghese Radio 1, ha ottenuto numerosi riconoscimenti dentro e fuori i confini nazionali anche grazie ai lavori svolti per il cinema. La collaborazione con Amanita Design è proseguita con Machinarium, per il quale la Dvorak ha mobilitato tutta la sua esperienza in ambito elettroacustico, consegnando al gioco scorci di sereno (”The Sea”), dediche raffinate alla musica degli Air (”Gameboy Tune”), schizzetti caricaturali elettronici (”The Black Cap Brotherhood Theme”). La sinergia con il comparto visivo è perfetta, facendo di questo insieme di rottami ossidati un mondo a cui ci si può affezionare.
Machinarium è il risultato di tre anni di lavoro appassionato e curato sin nei minimi dettagli dai giovani designer praghesi di Amanita. L’amore per le avventure punta e clicca, a loro giudizio magiche, li ha spronati a consegnare questo gioiellino sia ai bacucchi che ancora potete vedere in vestaglia e babbucce davanti ad un vecchio 386 col loro caro vecchio adventure pixelloso, sia ai pischelletti che non hanno ancora potuto apprezzare l’alchimia che nasce quando un puntatore si libra all’interno di un mondo bidimensionale disegnato a mano.
JackNapier
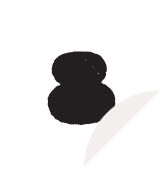
PS: Non l’ho incluso nel corpo della recensione per non fare il rompicoglioni, ma l’avessero renderizzato a 1080p, male non avrebbero fatto. Ad ogni modo, bisogna lodare la serietà di questi ragazzi nell’aver rilasciato simultaneamente tre versioni del gioco per altrettanti sistemi operativi (OS X, Linux e Windows).
Note
1. Nota di Aries, citando Wikipedia: pratica delle eccezioni alle teorie e di tutti i metodi della moderna e passata scienza, spesso espressa con un linguaggio apparentemente nonsense. La patafisica ha le sue regole che inglobano tutte le possibilità immaginifiche possibili.
